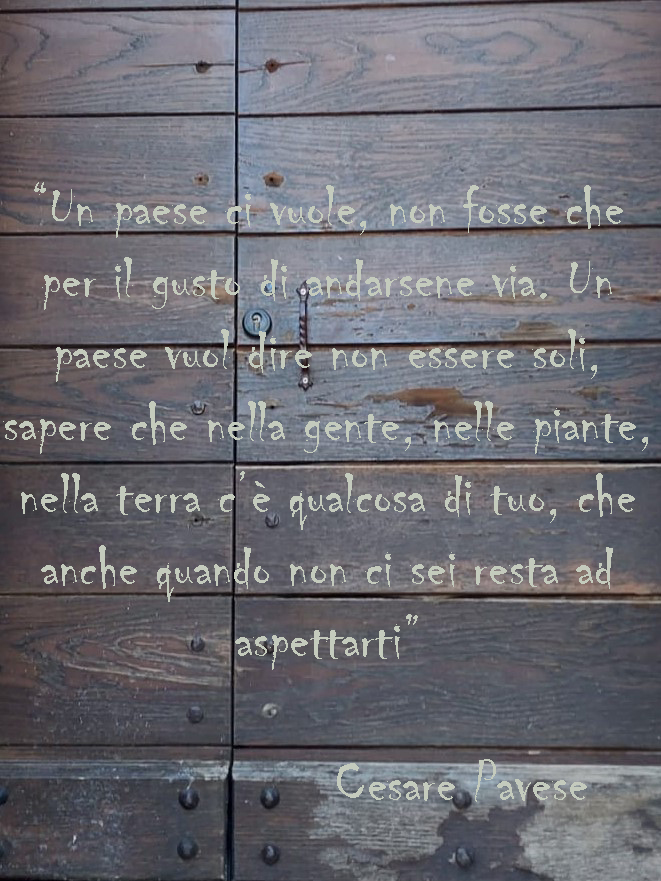Abbiamo incontrato Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo di RAI3, nella sua Torella del Sannio, in provincia di Campobasso.
 Domenico Iannacone
Domenico Iannacone
Domenico, ti immagino da ragazzo a Torella del Sannio, nella tua stanza, con una macchina da scrivere e il tuo sogno di diventare giornalista. Raccontaci questa fotografia.
Mi rivedo in una stanza, che però non era a casa mia. Si trattava di una stanza che un mio amico aveva prestato a me e ad altri due miei compagni. L’idea era quella di fare un giornale; è lì che si è innescata la necessità, la voglia di raccontare. Mi piaceva l’idea che anche qui a Torella del Sannio, in questo piccolo posto, ci potesse essere spazio per il racconto, anche con le storie più piccole, defilate, minime. A volte noi immaginiamo il racconto in maniera più epica, più altisonante; invece, anche qui come in tutti i posti, del resto, si possono raccontare storie.
In quella stanza avevamo un tavolo basso, una Lettera 32 della Olivetti e un pezzo di ciclostile: amavamo definirla redazione e ci piaceva l’idea di averne una proprio nel nostro paese. Questo ci faceva sentire in una sorta di sogno; proprio quel sogno che avevo sempre cullato dentro di me.
Ero un bambino affascinato dal racconto, letterario o giornalistico che fosse. Poi c’era stata anche un’influenza della televisione: ero ammaliato dai documentari di Comencini; devo dire che quella TV mi ha dato l’imprinting. Ogni tanto è come se riavvolgessi il nastro e rivedessi quella fase della mia vita; credo che quel momento mi sia rimasto dentro e lo ritrovo anche nelle cose che ho fatto e che faccio.

Anche la televisione di Gregoretti ti ha ispirato?
Gregoretti è stato un maestro dell’ironia e, al tempo stesso, della profondità; mai una leggerezza fine a sé stessa. Tra l’altro, con Ugo ho avuto la fortuna di intessere un rapporto di amicizia profonda. Quando mi chiamava al telefono mi diceva: «Mi piace, bello quello che tu hai fatto». Sapevo che mi stava dando una spinta, un incoraggiamento a continuare. Devo dire che lui aveva la capacità di entrare in punta di piedi: era di una delicatezza unica e anche la sua ironia non era mai sberleffo.
Oltre alla televisione, quali sono stati i tuoi riferimenti?
Forse, il primo elemento di rapporto con la parola l’ho avuto con la poesia. Mi interessava molto il giornalismo ma la poesia mi creava delle suggestioni incredibili. Ne ero un divoratore e, giovanissimo, scrissi ad Amelia Rosselli, la poetessa figlia di Carlo Rosselli. E lei mi rispose. Mi chiamò al telefono e mi disse: «Ho letto le tue cose; vieni a Roma, se me le porti le pubblichiamo sulla rivista La Tartaruga». Amelia era per me il punto massimo della poesia contemporanea e, quindi, ero contentissimo, mi si aprì un mondo. Con lei nacque un rapporto che è durato diversi anni, fino a poco prima della sua morte, avvenuta tragicamente.
Quel periodo lì ha rappresentato per me la vera formazione, anche quella giornalistica è avvenuta in quel contesto. Io con la poesia ho imparato ad essere un giornalista. Il giornalismo e la poesia sembrerebbero due mondi distanti ma in realtà sono attigui. L’idea di aver conosciuto tutti i poeti del ‘900 italiano, di aver introiettato esperienze, parole, suoni e metrica, mi ha formato e poi mi ha consentito di fare un lavoro di sintesi. La poesia ti spinge all’immersione nelle cose, a raffinarne il significato e il suono.
Ad un certo punto iniziano le tue esperienze da giornalista nelle testate regionali del Molise.
Ancor prima, a Roma avevo fatto i lavori più diversi: il lavapiatti, il cameriere, lo scaricatore ai mercati generali. Poi, cominciai a fare la spola tra la capitale e Torella del Sannio per fare le prime collaborazioni saltuarie con le testate locali molisane. Ciò mi spinse a fare ritorno in Molise, dove ebbi la possibilità di fare anche un lavoro più stabile: il rappresentante in un’azienda di salumi. Successivamente, iniziai a lavorare in una televisione privata molisana, Teleregione. Finché un giorno, una persona di Milano, che lavorava nella televisione pubblica, mi incontrò per strada e mi disse di aver visto alcuni miei pezzi televisivi e di averli apprezzati molto; mi propose di andare a lavorare a Milano, nella redazione di Okkupati, un programma di RAI3.
L’approdo in RAI avviene nel 2001. Dopo Okkupati, come prosegue il tuo percorso nella TV pubblica?
Dopo Okkupati, nel 2003 lavorai ad un programma, Super Senior, che aveva come autori Angelo Guglielmi e Bruno Voglino. Il tutto era incentrato su un gruppo di anziani che alloggiava in una casa e che aveva l’obiettivo di scrivere e rappresentare un’opera teatrale. Io mi occupai della selezione dei partecipanti e della regia in condivisione con altri colleghi.
Ebbi poi un momento di buco e così, assieme ad altre persone, decidemmo di autoprodurci un lavoro sul terremoto di San Giuliano di Puglia. Ricordo che ogni settimana scendevo in Molise e alloggiavamo in una casa, quasi un rudere, che stava a San Giuliano. Facemmo un documentario, firmato anche con Andrea Salvadore, che si chiamava Grammatica di un terremoto: angeli e diavoli a San Giuliano. Proponemmo il nostro lavoro in RAI ma non fu mandato in onda.
Ad un certo punto, venni a conoscenza del fatto che a Ballarò stavano cercando un inviato e mi proposi presentando proprio Grammatica di un terremoto. Giovanni Floris, dopo averlo visionato, mi disse che avrei potuto cominciare il giorno dopo. Fu un inizio folgorante. Alcuni colleghi mi guardavano con un po’ di spocchia, ma dopo la prima puntata feci un pezzo ogni settimana. Portai delle storie forti. Per la prima volta si cominciò a parlare di Scampia in televisione; andai dentro quel posto e lo feci con profondità. Si crearono sacche di opinione attorno a quel tema che non veniva rappresentato se non sui giornali, attraverso il racconto dei morti della faida di Secondigliano. Man mano mi conquistai una credibilità crescente. Neanche quei colleghi che mi guardavano con una sorta di pregiudizio, probabilmente perché venivo dalla provincia, poterono scalfirla. In realtà, proprio facendo televisione nella mia regione, avevo acquisito strumenti e competenze trasversali che poi mi hanno consentito di affrontare proficuamente l’esperienza in RAI.
Poi, programmi tutti tuoi: con I dieci comandamenti e Che ci faccio qui hai dato vita al giornalismo empatico; sei la voce di storie afone per le orecchie di una società distratta; hai dato rappresentanza alla fragilità granitica di persone speciali, al respiro e alle apnee delle periferie; hai fatto della gentilezza, della tenerezza, dell’ascolto rispettoso e della poesia i punti cardinali del tuo cammino professionale. Sei consapevole di quanto sia meravigliosa e, per certi versi, rivoluzionaria la tua televisione?
Aver scelto di arretrare rispetto alla tipologia prevalente del racconto televisivo mi ha permesso di esplorare mondi incredibili, dotati di una bellezza intrinseca straordinaria. Penso che la scelta di rallentare e, quindi, di ritrovare un ritmo più naturale nella narrazione televisiva non si possa definire rivoluzionaria; è un modo classico che è presente anche nella letteratura e che possiamo ritrovare anche nella prima televisione: basti pensare a Pasolini e Comizi d’amore, a Comencini, a Gregoretti; era una televisione che permetteva alle persone, nel momento in cui si vedeva una cosa, di trovare il tempo di riflessione ed elaborazione. E poi deve accadere ciò che succede nel cinema: se un film ti colpisce, il giorno dopo ci ripensi; e poi ci ripenserai anche nei giorni successivi. Se la televisione riesce a sortire questo effetto vuol dire che arriva in profondità. Io credo di aver colmato un vuoto in un periodo storico in cui mancava questo tipo di racconto televisivo; mi riferisco ad un vuoto emotivo. La televisione era fredda, era un racconto cronachistico, giudiziario, anche ben fatto; le mancava, però, l’immersione nell’emozione. Per certi versi è come se il giornalista, un po’ per rigore professionale e un po’ per presa di posizione, non avesse il modo di “sporcarsi le mani”. Per me, invece, quell’aspetto era significativo: io non potevo e non posso raccontare un luogo se prima non l’ho attraversato pienamente. Condivido una cosa molto bella che diceva Kapuściński sul concetto di racconto giornalistico: se tu vuoi raccontare una persona devi trascorrerci del tempo assieme; non puoi farlo diversamente, altrimenti racconti soltanto la superficialità delle cose.
Quanto è importante mettere al centro le periferie, quelle dei luoghi e quelle dell’anima?
È importantissimo. Le periferie sono centrali nella mia narrazione: lì trovo i miei reagenti morali, le mie interfacce, le mie privazioni, le mie fragilità. Ritrovo tutti questi elementi perché, facendo quel lavoro immersivo di cui parlavamo prima, è come se compenetrassi delle vicende umane, delle storie che mi lasciano tutt’altro che indifferente. Per molti anni ho vissuto un sovraccarico emotivo, avevo dei momenti in cui non sapevo come scaricare tutto quello che mi arrivava addosso. Ora sono diventato più bravo perché, in qualche modo, so anche proteggermi maggiormente rispetto al passato.
Devo dire che, in assoluto, le persone più belle, più incredibili, le ho trovate nelle periferie.
 Torella del Sannio
Torella del Sannio
In Da casa tua a casa mia, assieme a Franco Arminio, hai dato spazio alla poesia dei paesi. Raccontaci del tuo legame con Torella del Sannio.
Dopo il primo lockdown, chiamai Franco Arminio e gli proposi di fare un viaggio da casa sua a casa mia per raccontare l’anima degli spazi minimi, dei luoghi defilati e delle piccole comunità. Quando siamo passati dalla sua dimensione alla mia, che è ancora più piccola, ci accorgemmo istantaneamente del silenzio incredibile che c’era. Quando torno a Torella del Sannio mi riabituo all’assenza di rumori: la mia casa è silenziosissima, sento perfino il ronzio delle api. Quando faccio ritorno a Roma è sempre difficile riadattarmi ai suoni della città.
Penso che chi abita qui non sia ai margini, come si potrebbe pensare; anzi, ritengo che viva una condizione di privilegio: stare qui ti consente di entrare in contatto con una moltitudine di cose. Ricordo che Franco Arminio mi disse che, in realtà, a Torella, tra alberi ed esseri viventi, c’erano più o meno due milioni di abitanti. Aveva ragione. Poco tempo fa, davanti a casa mia è venuta una volpe bellissima, con una grande coda rossa; io stavo seduto sul muretto di casa e la vidi arrivare. Ci siamo fissati a lungo, lei era ferma e mi guardava con occhi vispi. Sono rimasto immobile per non spaventarla e non mi sono fatto prendere dalla voglia di filmarla: mi sono goduto quel momento. Penso sia tornata qualche altra volta perché ho visto delle tracce sul terreno antistante la mia abitazione; devo dire chi mi piacerebbe molto rincontrarla. Ecco, per me questo posto ti consente anche relazioni di questo tipo.
 Torella del Sannio (Foto di Alessandro Iannacone)
Torella del Sannio (Foto di Alessandro Iannacone)
E cosa significa per te la “finestra sul mondo” che hai realizzato nella tua casa e che abbiamo visto in Da casa tua a casa mia?
La finestra di casa mia a cui ti riferisci mi piace molto, mi lascio quasi commuovere ogni volta da quel luogo. Mi ritengo molto fortunato ad avere quello spalto, quella visione: osservo l’infinito, le stagioni che cambiano, la mutazione dei colori.
Ricordo che quando visionai la casa per valutare di acquistarla, appena entrai vidi la finestra e me ne innamorai all’istante; posso dire di aver acquistato la casa perché c’era quella finestra.
Hai chiamato la tua casa Itaca. Ciò lascia intendere che farai ritorno a Torella?
Ma certo che torno! Il mio lavoro, in questo momento, non mi consente di farlo in modo definitivo ma, comunque, riesco a venire a Torella molto spesso. In ogni caso, è indubbio che appena sarà possibile tornerò a viverci in pianta stabile. Non può che essere così: qui non c’è mai un elemento che ti espelle, c’è sempre un’atmosfera inclusiva, ci si trova costantemente di fronte ad una sorta di bene circolare e ad una generosità diffusa.
 Torella del Sannio
Torella del Sannio
Il tuo giornalismo è fatto anche di silenzi e pause: alle domande e alle risposte viene dato il tempo di respirare e di decantare. Per certi versi c’è un parallelismo con la vita dei piccoli centri che scorre con maggiore lentezza rispetto a quella delle città?
Nella mia narrazione il ritmo e la lentezza sono diventati una cifra narrativa. Non sono soltanto una cifra estetica, sono sostanza. La pausa per me è sempre piena di significato, non è mai un vuoto. In televisione i vuoti non sono ammessi; invece, si possono dire tante cose anche nel silenzio, ascoltando soltanto. Io dico sempre che l’elemento che contraddistingue la mia narrazione è una sorta di maieutica socratica in cui sono testimone ma non sovrasto mai la testimonianza. I silenzi sono una parte determinante; io, assieme ai telespettatori, sono quello che ascolta. Quindi, in questa trasmutazione c’è il senso di un silenzio che ha a che fare con il recepimento della testimonianza, la quale ha valore se le viene dato il tempo di essere assorbita.
In effetti, si può riconoscere un parallelismo con il ritmo e la lentezza con cui la vita scorre nei piccoli centri.
 Torella del Sannio (Foto di Domenico Ciamarra)
Torella del Sannio (Foto di Domenico Ciamarra)
Pensi che si possa arrestare – e magari invertire – il processo di spopolamento dei piccoli centri del nostro Paese? È utopistico puntare su un’emigrazione di ritorno dalle grandi città ai paesi, magari puntando sullo smart working?
Con il Covid c’è stato una sorta di blocco totale a livello mondiale: improvvisamente ci siamo sentiti prigionieri nelle città. Nei piccoli paesi questa sensazione si è manifestata in maniera molto più attenuata.
La pandemia ha favorito lo svelamento del valore delle possibilità che ci possono essere nei paesi: l’ampiezza degli spazi, il verde, il paesaggio, la libertà di movimento. E poi c’è un discorso legato alla tranquillità, al tempo da dedicare a sé stessi, al ritmo sostenibile della vita. È chiaro che, in un momento in cui la tecnologia ci ha permesso di poter bypassare la presenza fisica per alcune tipologie di lavori, si aprono nuovi scenari: se puoi fare il tuo lavoro in una condizione di questo tipo allora sei doppiamente privilegiato.
In una fase storica in cui le città hanno perso il loro smalto, questo potrebbe essere il momento della grande opportunità dei paesi. Lo smart working potrebbe consentire, ad alcune categorie di lavoratori, di svolgere la propria attività professionale senza dover fare il salto verso luoghi lontani, potendo così rimanere o, per chi è già emigrato, fare ritorno nei propri paesi. Inoltre, nei piccoli comuni la vita costa meno e la casa di proprietà non è una chimera. Lo slogan può essere: “qui la vita è possibile!”. E può valere per Torella come per i piccoli paesi in generale. L’auspicio è che anche i fondi del PNRR possano spingere in questa direzione.
 Torella del Sannio (Foto di Marco D’Alessandro)
Torella del Sannio (Foto di Marco D’Alessandro)
Quali sono i tuoi luoghi del cuore? E quelli dell’anima?
Il mio luogo del cuore è Torella del Sannio.
Poi esistono tanti luoghi che ho attraversato, che sono diventati i miei luoghi dell’anima; due su tutti: Scampia e il campetto di Borgo Vecchio a Palermo. Sono rimasti scolpiti dentro di me non soltanto sotto l’aspetto visivo; ogni volta che ci penso ho una reminiscenza che coinvolge tutti i sensi. Perché in quei luoghi ci ho passato del tempo, ho vissuto delle emozioni forti e profonde.
Spesso, le nostre vite prendono determinate direzioni anche in funzione degli incontri che facciamo: quali sono state le persone che hanno illuminato la tua strada?
Ce ne sono state e ce ne sono tante. Devo dire che, negli ultimi anni della sua vita, Andrea Camilleri è stato per me un riferimento centrale; ci siamo voluti molto bene. Con Andrea c’era un rapporto molto intimo, lo sentivo come una figura paterna; mi parlava sempre in modo molto dolce. Nell’ultimo periodo ci sentivamo telefonicamente, anche solo per dirci che ci volevamo bene; era una forma di rassicurazione che ci permetteva di tenere il nostro legame sempre caldo. Le conversazioni che avevo con lui erano per me sempre illuminanti. Aveva la capacità di intuire le cose, il futuro. Era un grande affabulatore. Andrea Camilleri mi manca tantissimo.